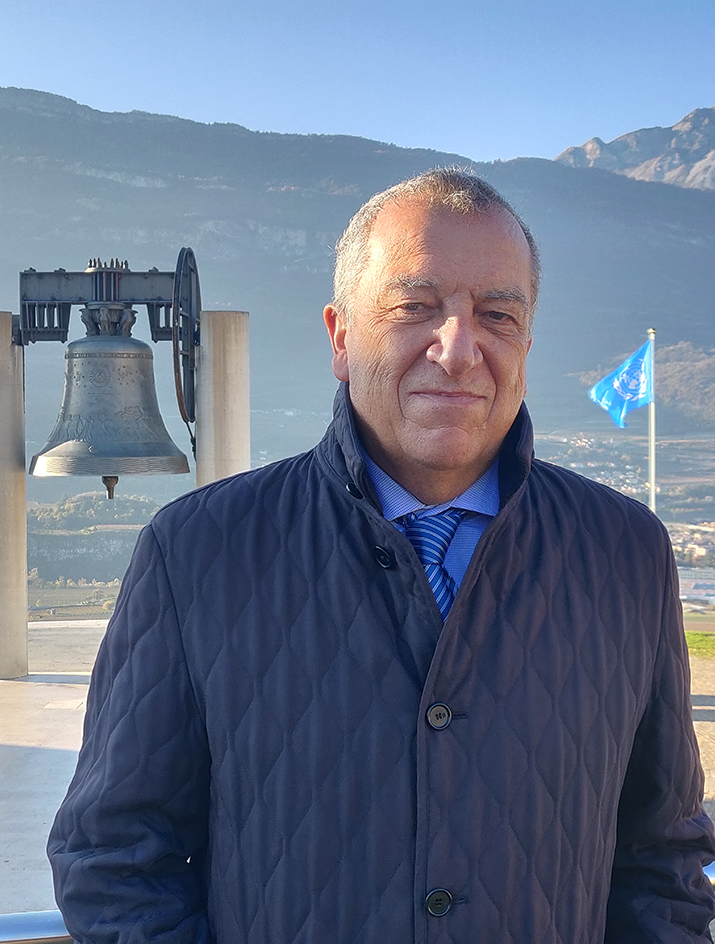Gli ambienti dell’opposizione turca non hanno dubbi nel sostenere che la pesante (2 anni e 7 mesi di carcere) condanna inflitta lo scorso dicembre al sindaco di Istanbul, Ekrem Imanoglu, ha rappresentato il prematuro e inaspettato “calcio d’inizio” della campagna per le elezioni presidenziali che, dopo varie indecisioni, sembrerebbero ora definitivamente fissate in data 14 maggio.
Tale convinzione si basa su due fattori strettamente collegati. Innanzitutto, la grande popolarità goduta dal personaggio ora minacciato di interdizione politica, il primo esponente di un partito non governativo a proiettarsi, nel 2019, alla guida della più importante città del Paese a conclusione di un tormentato percorso caratterizzato da una doppia votazione. In secondo luogo la constatazione della eccessiva severità della pena, a fronte di un comportamento che, in un sistema democratico, sarebbe risultato pressoché immune da censure, perché inquadrabile nel sacrosanto principio della libertà di espressione.
Imanoglu si era infatti manifestato in termini, oggettivamente non del tutto eleganti, nei confronti dei componenti del Tribunale elettorale, che avevano imposto, a distanza di sei mesi dal primo, la ripetizione dello scrutinio municipale (nuovamente da lui vinto).
Gli esponenti dell’opposizione, recentemente coalizzatisi nel cosiddetto Tavolo dei Sei, sono concordi nel considerare quanto accaduto alla stregua di una grossolana manovra per impedire a Imanoglu di presentarsi al vitale appuntamento di maggio, liberando in tal modo il presidente in carica, Recep Tayyip Erdogan, da uno dei rivali più temibili sulla strada della rielezione.
L’”incidente di percorso” (se tale si può chiamare) sul quale ci siamo, per la sua rilevanza, soffermati, avviene in una congiuntura storica in cui la Turchia si trova, per svariati motivi, a doversi ripetutamente confrontare con i riflettori della attenzione internazionale.
Da parte dei Paesi occidentali, Unione Europea e Stati Uniti, è percettibile nei confronti della sua leadership un senso crescente di frustrazione, che trova la principale ragione d’essere nella collocazione assunta da Ankara nel conflitto russo/ucraino. Si tratta di un posizionamento che appare soprattutto dettato da ragioni di opportunismo, ciò che lo rende inevitabilmente privo di univocità e di coerenza.
Se è indubbio, infatti, che Ankara stia fornendo armamenti all’Ucraina - in particolare gli efficaci droni Bayraktar TB2 - avendo in precedenza chiuso alle navi militari russe l’accesso al Mar Nero, è altrettanto vero che già all’indomani del 24 febbraio la sua dirigenza aveva chiaramente rifiutato di associarsi alle sanzioni decretate da Bruxelles e Washington, qualificate come «inutili e controproducenti», così come non si era opposta ai progetti, pubblicamente annunciati da svariate imprese russe (fra le quali Gazprom), di trasferire sul suolo anatolico i propri “quartieri generali” sinora localizzati in altri Paesi europei.
Va altresì sottolineato come, dopo l’invasione dell’Ucraina, il “sultano Erdogan” non abbia di certo interrotto i suoi rapporti con lo “zar Putin” (al quale lo unisce un’innegabile affinità umana e politica) da lui incontrato in svariate occasioni e in vari formati. In trilaterale con il presidente iraniano Raisi a luglio a Teheran, in bilaterale a Sochi il mese successivo, con i Paesi dell’area centro-asiatica a Samarcanda e Astana. Su tale sfondo, è giocoforza riconoscere come l’interesse nazionale (la Russia rappresenta per la Turchia il terzo partner commerciale in termini assoluti e, più in dettaglio, il primo fornitore di gas e il principale Paese di provenienza dei flussi turistici) abbia nettamente prevalso su altre possibili considerazioni, conferendo ulteriore sostanza a quel “partenariato privilegiato” che ha visto l’export turco verso la Federazione Russa addirittura raddoppiare nel corso degli ultimi dieci mesi.
Dovendosi, in un giudizio obiettivo, valutare anche i lati positivi di un rapporto “poco esemplare”, sembra comunque corretto evidenziare come il cosiddetto Accordo sul grano raggiunto la scorsa estate sotto l’egida Onu per permettere la continuazione di rifornimenti vitali per la sopravvivenza di numerosi Paesi africani, è stato reso possibile soprattutto grazie al canale di dialogo esistente fra Mosca e Ankara.
Contribuisce ad alimentare il “pacchetto” di recriminazioni occidentali anche il fatto che la Turchia abbia preso in considerazione di ritirare il veto all’allargamento della Nato a Svezia e Finlandia che chiedevano di aderirvi, solo dopo avere ottenuto dalle due capitali l’assicurazione che l’appoggio sinora concesso sui rispettivi territori agli esiliati curdi del Pkk non sarebbe stato prorogato.
Una presa di posizione, quella sopra descritta, che se non mette certamente in discussione l’appartenenza di Ankara all’organismo multilaterale di sicurezza, convalida il ragionamento di chi ritiene la Turchia “un mal di testa con il quale occorre comunque convivere”. Inoltre, essa si rivela controproducente anche in ambito europeo. L’aspirazione della Turchia di essere, un giorno, accolta nella famiglia Ue concludendo con successo il percorso iniziato nel lontano 1999 proprio ad Helsinki (corsi e ricorsi della storia …) con l’ottenimento dello status di Paese candidato, aveva sinora trovato nella Svezia, all’interno dei 27, uno dei membri più sensibili. Dopo quello che è a tutti apparso come un vero ricatto, è scontato che Stoccolma assuma d’ora in poi un orientamento ben diverso.
Su detto sfondo, nelle analisi di qualificati commentatori, interni e stranieri, si va sempre più diffondendo il sospetto che l’esistenza di un paio di crisi internazionali (oltre all’Ucraina anche il dossier siriano mantiene piena attualità, con la Turchia impegnata nella creazione di una “area cuscinetto” per scongiurare i paventati attacchi curdi, senza dimenticare le ricorrenti “punture di spillo” con la Grecia per la delimitazione degli spazi aerei e marittimi e lo sfruttamento delle risorse dei fondali) servano a Erdogan per deviare l’attenzione di molti connazionali dai serissimi problemi interni. Primo fra tutti la galoppante inflazione (incrementatasi dell’80 per cento in un anno) che riduce sensibilmente il valore reale di salari e risparmi e che è altresì alla base del pesante deprezzamento della lira turca e dell’aggravarsi delle condizioni di disequilibrio sociale.
A livello di programma elettorale, l’opposizione si batte per un ritorno al sistema parlamentare in vigore sino al 2018, fino cioè alla riforma introdotta dal presidente Erdogan come reazione al fallito “putsch” di due anni prima, costato - come noto - a migliaia di cittadini turchi condanne a lunghi periodi di incarcerazione oltre a una massiccia politica di epurazione da cariche pubbliche e posti di lavoro. A essere stigmatizzato dal “Tavolo dei Sei” è soprattutto l’eccesso di potere nelle mani di Erdogan e dei suoi partigiani e la mancanza di qualsiasi sistema interno di check and balances. Di tale assenza una vittima designata è certamente il People’s Democratic Party (Hdp), il principale partito curdo, costantemente sotto minaccia di chiusura in quanto arbitrariamente assimilato a una formazione terroristica. Pur con il margine di errore che caratterizza le previsioni di voto svolte con mesi di anticipo, gli esperti convergono nel ritenere insufficiente a Erdogan - beninteso in caso di consultazioni fair and free - la ultra trentennale militanza politica - fondatore del Partito della Giustizia e dello sviluppo (Akp), sindaco di Istanbul dal 1994 al 1998, primo ministro dal 2003 al 2014 e da allora ininterrottamente Capo dello Stato - per imporsi al primo turno come il dodicesimo presidente della Turchia. E, in caso di ballottaggio, con la scontata decisione di tutti i partiti di opposizione di coalizzarsi contro la sua candidatura, le prospettive di una sua sconfitta diverrebbero, secondo tali analisi, realistiche.
A titolo di considerazione finale, non è fuori luogo ricordare come nel 1997 Recep Tayyip Erdogan, all’epoca primo cittadino di Istanbul, sia stato condannato - in un contesto politico interno ben diverso dall’attuale - per un reato d’opinione non dissimile a quello imputato oggi a Imanoglu. Per valutazione generale, la sentenza segnò l’inizio della, sin qui inarrestabile, ascesa politica del “sultano”. Un altro tema su cui riflettere, a distanza di un quarto di secolo, in una Turchia che si accinge a effettuare una scelta fondamentale sul suo prossimo futuro.
Il Reggente, Marco Marsilli