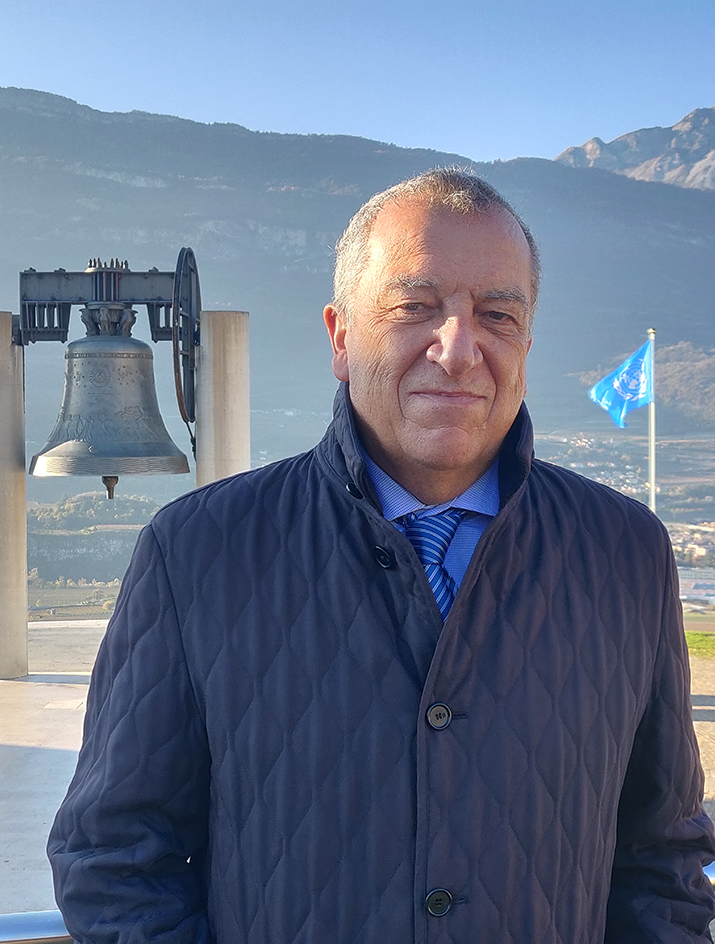Il 5 novembre prossimo un corpo elettorale di oltre 200 milioni di persone sarà chiamato alle urne per eleggere il 47o Presidente della storia degli Stati Uniti d’America.
Al momento della pubblicazione del presente articolo mancheranno ancora otto mesi a quell’importantissimo appuntamento, ma appare sin d’ora chiaro - a meno del prodursi del più inverosimile dei copioni simil-cinematografici - come a contendersi il prestigioso, quadriennale mandato saranno l’attuale inquilino della Casa Bianca e il suo immediato predecessore nell’incarico.
L’assoluta mancanza di suspense che accomuna i due soli partiti, il Democratico e il Repubblicano, in grado di esprimere candidati “eleggibili” su scala nazionale, discende in buona parte dall’inequivocabile esito delle cosiddette “primarie”, vale a dire delle pre-consultazioni locali che, pur con modalità diverse, caratterizzano tutti gli stati dell’Unione. Quelle sin qui svoltesi si sono infatti trasformate, all’interno dei rispettivi schieramenti, in indiscutibili affermazioni tanto per Joe Biden che per Donald Trump, inducendo un buon numero di sfidanti a ritirarsi da campagne tanto costose quanto votate, per gli stessi, all’evidente insuccesso.
Consuetudine vuole che, potendo contare sulla “rendita di posizione” della Casa Bianca e sullo scontato appoggio dei vertici del proprio partito, il Presidente in esercizio sia decisamente meno esposto al pericolo di concorrenza interna.
Dove tale tipo di competizione si manifesta, di norma, con maggior vivacità, è nella forza all’opposizione, dal momento che - almeno in teoria - i vari sfidanti partono (o dovrebbero partire) da posizioni di sostanziale parità. In effetti, le iniziali presenze fra i “papabili” di due alternative qualificate a Donald Trump, vale a dire il Governatore della Florida Ron DeSantis e l’ex Ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Nikki Haley, lasciavano presagire, in occasione della convention di Milwaukee di metà luglio, la possibilità di una designazione finale meno scontata. Ma, come sopra ricordato, i riscontri delle primarie, benché parziali, hanno finito per lasciare il segno, inducendo il primo a ritirarsi in discreto ordine e la seconda a gettare la spugna dopo gli esiti per lei deludenti del “Super Tuesday” di inizio marzo.
Ritornando al tema della mancanza di suspense che appare contraddistinguere le elezioni di novembre, sembra lecito porsi l’interrogativo del perché nel Paese più ricco, potente, economicamente dinamico e tecnologicamente avanzato del pianeta, una scelta così fondamentale anche dal punto di vista dei futuri equilibri internazionali, veda come protagonisti due personalità decisamente lontane dal prestigio e dalla credibilità che dovrebbero contrassegnare il profilo del 46o successore di George Washington. Oltre a vari capi di accusa per casi di corruzione, sottrazione/occultamento di documenti e harassment sessuale, su Trump pesano infatti come macigni le indiscutibili connivenze avute nel gennaio 2021 con gli assalitori di Capitol Hill, storicamente la più grave minaccia interna mai portata alla democrazia statunitense. Connivenze talmente gravi da indurre le Corti di alcuni Stati della Federazione a dichiararne la ineleggibilità (tali sentenze sono state però, molto recentemente, “cassate” dalla Corte Suprema).
Sull’altro lato, se l’etica personale di Biden appare oggettivamente immune da critiche di sostanza (nonostante il giudizio positivo non si estenda a esponenti del suo stretto entourage familiare), è soprattutto la sua evidente senilità a causare diffuse preoccupazioni. Esemplificata nella contundente definizione del Procuratore speciale Robert Hur («un anziano di buone intenzioni e di scarsa memoria») nonché nella più popolare etichetta di sleepy Joe, essa autorizza l’emergere di fondati dubbi circa il pieno godimento di quelle doti di coerenza, lucidità e reattività intellettuale che sono indispensabili nel disimpegno del più importante e delicato incarico di governo a livello mondiale.
Cercando di rispondere ai quesiti, nel caso di Trump fa premio, al di là di tutte le altre considerazioni, la convinzione che per il Grand Old Party (così come per le potenti lobbies che lo sostengono e lo finanziano) egli rappresenta ancora oggi l’esponente repubblicano più idoneo a far convergere sul partito i voti dell’elettorato statunitense. Non va infatti dimenticato che il 5 novembre, al di là dell’elezione indiretta del nuovo Presidente, dovrà essere rinnovato per intero il Congresso (attualmente a maggioranza repubblicana) e per un terzo della sua composizione anche il Senato (controllato invece dai Democratici).
Nel caso di Biden, il discorso è più complesso. La sua vittoriosa elezione del 2020 era stata infatti vista da molti dei suoi sostenitori come il necessario “anello di congiunzione” sulla via di un prossimo, netto ricambio generazionale. A tale passaggio di testimone doveva preludere il “ticket” con Kamala Harris, a favorire cioè l’ingresso nella Casa Bianca, 4 anni più tardi, a una brillante, competente e “giovanile” sessantenne. Rimasto il progetto sulla carta - per ragioni attinenti alla mancanza di carisma e al conseguente ridimensionamento della popolarità della attuale Vicepresidente - ai Democratici non è rimasta altra soluzione, per utilizzare una formula irriverente ma efficace, del ricorso all’“usato sicuro”.
In vista del traguardo del 5 novembre, la contesa si annuncia serrata e, almeno a questo stadio, di impossibile previsione, dal momento che il pur non irrilevante vantaggio di cui, secondo la maggioranza delle rilevazioni, gode attualmente Trump (48% rispetto al 43% secondo il «NewYork Times») appare tutt’altro che incolmabile.
Come costantemente accaduto nelle elezioni statunitensi, non saranno tanto le questioni internazionali (per quanto ampia possa essere la “esposizione” mediatica delle stesse) a orientare in un modo o nell’altro il responso dei votanti, quanto quelle di carattere interno. Sulle prime torneremo in successivi commenti, limitandoci in questa sede a sottolineare come, in caso di affermazione di Trump, il sostegno americano al governo dell’Ucraina, praticamente illimitato dal 24 febbraio 2022 a oggi, andrebbe incontro a forme di attenuazione. Le sue recenti, provocatorie dichiarazioni sul ruolo della Nato e il prolungato silenzio seguito all’“omicidio di Stato” di Aleksei Navalny, lo stanno a testimoniare.
A proposito delle seconde, saranno i dossier dei diritti civili, della sicurezza sociale, della maggiore distribuzione del welfare e del cambiamento climatico a costituire le priorità della campagna del Presidente in carica. A essi lo sfidante opporrà quelli della riduzione delle imposte, della minore presenza dello Stato nell’economia, della immutata libertà nella vendita delle armi e della maggiore severità nella repressione dell’aborto e dei comportamenti sociali “non convenzionali”.
Ciò detto, nella unanime valutazione di ambienti politici e media la “madre di tutte le battaglie elettorali” sarà costituita dal fenomeno della immigrazione e della sua regolamentazione. Secondo i dati ufficiali, sono oltre 5 milioni le persone che, durante la presidenza Biden, hanno varcato, per lo più clandestinamente, la frontiera meridionale del Paese. Si tratta di un flusso che Democratici e Repubblicani, per una volta concordi, considerano in prospettiva insostenibile, pur divergendo radicalmente circa le soluzioni più idonee per farvi efficacemente fronte. Si tratta di decisioni straordinariamente rilevanti, in quanto destinate a sancire la riconferma alla Casa Bianca di Joe Biden o il ritorno a vele spiegate nell’oval office di Donald Trump, riproponendo pertanto anche oltre-Atlantico i dubbi e le incertezze che, nella stessa materia, caratterizzano le scelte di fondo di pressoché tutti i governi del Vecchio Continente.
Il Reggente, Marco Marsilli