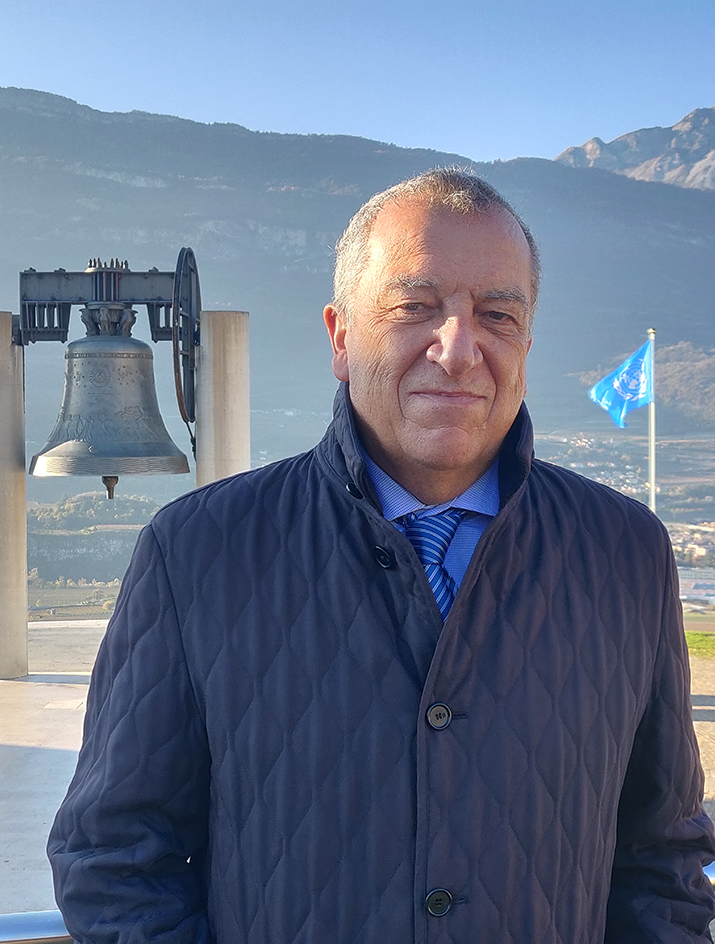Come ampiamente prevedibile, la ricorrenza del primo anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina è stata contraddistinta, su entrambi i fronti, da una fitta serie di eventi. Per il fatto di avere costituito oggetto di ampia divulgazione da parte degli organi di informazione italiani e stranieri, essi richiedono, per i nostri specifici fini, solo una sintetica citazione.
La «storica» missione a Kiev del presidente statunitense Biden; il «torrenziale» discorso di Vladimir Putin davanti alla “nomenklatura” del suo Paese; la “delicatissima” visita a Mosca del responsabile della politica estera cinese, Wang Li; l’“atteso” colloquio, nella capitale ucraina, fra Zelensky e il presidente del Consiglio Meloni; la nuova Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il raggiungimento di una Pace «complessiva, giusta e duratura», si sono così succeduti a brevissima distanza di tempo l’uno dall’altro, e questo per limitarsi agli episodi più significativi. Ognuno di essi è destinato a lasciare strascichi di varia e complessa natura che sarebbe prematuro tentare di analizzare in questo momento.
Limitandoci agli elementi noti, il conflitto russo-ucraino, ormai entrato nel secondo anno di drammatica esistenza, continua a rappresentare una gravissima ferita aperta nel cuore dell’Europa. Lo è per molte ragioni: per l’elevato numero di perdite umane, dal lato degli aggrediti così come degli aggressori; per l’immane devastazione di infrastrutture di ogni genere, con collegati imponenti costi di ricostruzione; per le efferate violenze commesse dalle truppe di occupazione ai danni delle popolazioni residenti; per il solco, incolmabile per generazioni, venutosi a creare fra gli abitanti di due nazioni, contrassegnate sì da forti contrasti politici ma anche da una storia e da una identità, etnica, religiosa e culturale, strettamente intrecciate.
Accentua ulteriormente un generale, profondo senso di smarrimento e impotenza la constatazione di come poco, o nulla, di solido esista, in questo momento, su cui poter costruire un qualsiasi tentativo di “rappacificazione”. È ormai avvolto nell’oblio il ricordo delle trattative condotte, nel primo mese di guerra, da delegazioni (di basso profilo, va riconosciuto) di Mosca e di Kiev, allo scopo di porre fine alle ostilità concordando reciproche concessioni, trattative sfociate in un nulla di fatto.
Da mesi, ormai, vige infatti la politica del “muro contro muro”, nella quale nessuna delle due parti è disponibile a fare un passo indietro: per timore di far cadere in mano a Mosca ulteriori parti di territorio nazionale, nel caso di Zelensky, per paura di perdere la credibilità sul fronte interno (di quella sul piano internazionale è andata irrimediabilmente smarrita qualsiasi traccia), nel caso di Putin.
L’enfasi del momento, con il conflitto entrato in una prolungata fase di logoramento e di attrito e da una, si vedrà quanto duratura, ripresa dell’offensiva russa sui vari fronti (nel Donbass, a Kharkiv, a Zaphorizhzhia e in altri punti strategici) sembra essere pressoché esclusivamente concentrata sull’impiego di armi sempre più sofisticate e performanti. Al di là dei combattimenti in corso, il loro utilizzo appare essenziale anche per preparare al meglio delle rispettive capacità quelle operazioni a più ampio raggio che entrambi gli schieramenti, ovviamente con finalità opposte, hanno preannunciato di volere avviare nel corso delle prossime settimane.
Da questo punto di vista, il coinvolgimento del blocco euro-statunitense, formato dai membri di Unione Europea e Nato (meno la Turchia, mantenutasi sin qui sostanzialmente equidistante fra i due contendenti) si va facendo sempre più totalizzante, approssimandosi a una situazione di vera e propria “co-belligeranza”. In termini concreti, esso si traduce in una nuova serie di deliveries militari che - come nel caso dei carri armati Leopard 2 - ha sollevato qualche dubbio sulla esclusiva natura “difensiva” degli armamenti consegnati alle forze ucraine. Se per i mezzi corazzati la linea divisoria può non essere del tutto chiara, che dire dei nuovi desiderata chiaramente espressi dal presidente Zelensky al Consiglio europeo del 9 febbraio e negli immediatamente precedenti incontri en petit comité a Londra e Parigi? Lì, il discorso è chiaramente caduto sul settore aeronautico (le cosiddette “ali della libertà”, rappresentate da jet da combattimento F-16) e sui missili di lungo raggio, dei quali la portata offensiva è incontrovertibile. Si tratta, nelle valutazioni di Kiev, di compensare il fortissimo divario numerico esistente con la Federazione Russa sia dal punto di vista degli effettivi (si ricorda che la popolazione ucraina è di 4 volte inferiore) che degli armamenti (anche sul piano dei volumi di scorte esistenti nei depositi). Al tempo stesso, fornisce un’idea chiara della dimensione del coinvolgimento euro-statunitense il fatto che - secondo stime attendibili - l’ammontare delle sole forniture militari americane all’Ucraina abbia superato sul piano dei costi, per il 2022, la somma complessivamente destinata nel 2020 a tre tradizionali alleati degli Stati Uniti, quali Afghanistan (prima, ovviamente, della sua riconquista da parte dei Mujahidin) Egitto e Israele.
Sin qui l’Occidente (nella configurazione geografica sopra ricordata) ha mostrato un’encomiabile coesione, riuscendo ad amalgamare al proprio interno sia le impostazioni di chiusura radicale e senza appello nei riguardi di Mosca, sostenute in primo luogo dai membri del cosiddetto «Gruppo di Bucarest» (formato dai 9 Paesi del “fronte Est” della Nato), sia di quei membri maggiormente consci della necessità di riaprire, prima o poi, una qualche forma di dialogo con quella capitale. Di tale disomogeneità costituiscono eloquente conferma i recenti sondaggi relativi all’atteggiamento nei confronti della guerra delle locali opinioni pubbliche, anche questi diffusamente riportati dai media.
Di una sostanziale fermezza di fondo formano comunque testimonianza inequivocabile i ben 10 pacchetti di misure sanzionatorie adottati dalla Ue nei 12 mesi successivi all’aggressione, integrati da provvedimenti via via più mirati e invasivi, paragonati dall’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri Borrell - con un accostamento indicativo degli umori del momento - «all’arsenico, che agisce lentamente, ma in modo irreversibile».
In parallelo, sta proseguendo a buon ritmo anche il percorso, proceduralmente molto complesso, di adesione dell’Ucraina all’Unione, a seguito delle visite a Kiev dei presidenti della Commissione e del Consiglio europeo nonché di quella, sopra accennata, di Zelensky a Bruxelles. Su tale sfondo non appare fuori luogo chiedersi se al convinto appoggio sin qui accordato da Washington (da ultimo, e non si può in maniera più chiara e quasi «sfrontata», dallo stesso presidente Biden nella sua visita-lampo a Kiev) e da Bruxelles al governo ucraino, sul piano militare non possano (o, piuttosto, non debbano) affiancarsi con carattere di urgenza anche iniziative, delle quali è autorevolissimo sostenitore il Santo Padre, finalizzate a porre fine a uno spargimento di sangue di cui non si intravvede la fine. A confermare quanto precede basterà richiamare alla memoria le recentissime dichiarazioni di generali di Putin che stimano in ulteriori 24 mesi di combattimenti il periodo necessario per imporre la “pax russa” all’Ucraina. Un periodo di tempo in grado di far deragliare definitivamente un convoglio già oggi impegnato lungo un percorso impervio e pressoché privo di reti di protezione.
Del resto, se le origini del conflitto sono evidenti al di là di ogni possibile dubbio e se i responsabili dello stesso dovranno essere tradotti, quando sarà possibile farlo, davanti alle competenti istanze di giustizia internazionali (Tribunale dell’Aja), allo stato degli atti le conseguenze nel medio e lungo periodo rimangono imprevedibili. Dal suo osservatorio del Palazzo di Vetro, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, in un implicito riconoscimento dell’impotenza della Organizzazione da lui presieduta, ha constatato come le prospettive di Pace stiano sempre più cedendo il passo a un'ulteriore recrudescenza degli scontri armati e come «mai nella nostra vita abbiamo visto crescere i rischi di minaccia nucleare».
Il ricorso a un possibile facilitator in grado di avviare un percorso di intermediazione fra le parti, tanto impegnativo nella messa in moto quanto incerto negli esiti, appare a questo punto difficilmente procrastinabile.
A giudizio dello scrivente, detto ruolo non potrebbe essere assunto né dall’Europa (troppo schierata) né delle Nazioni Unite (paralizzate dal sistema del veto) né da potenze intermedie come la Turchia o Israele (carenti di autorità e, per quanto concerne la prima, alle prese con i gravissimi problemi provocati dal recente, devastante terremoto). Per la vitale rilevanza degli interessi in gioco - sotto l’aspetto politico/militare, geo-strategico, economico/finanziario e di altra natura - una coordinata, parallela “discesa in campo“ di Stati Uniti e Repubblica Popolare cinese apparirebbe, nella circostanza, pienamente giustificata. Di fronte alle “raccomandazioni” a raggiungere un cessate-il-fuoco, primo passo di una futura intesa, né Zelensky (se messo sotto pressione da Biden) né Putin (se sollecitato in tal senso da Xi Jinping) potrebbero sottrarsi a tale compito, dal momento che nell’attuale congiuntura internazionale non esiste un “potere terzo” in grado di opporsi a una misura decisa di comune accordo dalle due super-potenze mondiali.
In quest’ottica, alla proposta di «piano di Pace» presentata dalla Cina in connessione con la visita a Mosca del ministro degli Esteri Wang Yi va riconosciuta a nostro avviso una valenza positiva, anche se molte delle disposizioni che vi sono contenute, ispirate alla primaria esigenza di non antagonizzare né i russi né gli ucraini, finiscono per risultare ambigue se non addirittura contraddittorie. Non a caso, il presidente Zelensky si è subito dichiarato disponibile a un incontro con l’omologo cinese nell’intento, non dichiarato ma intuibile, di smuovere il “dragone” dalla consolidata posizione di “neutralità” filo-russa. Tale ambigua equidistanza è uscita confermata, qualche giorno fa, dall’astensione cinese in sede di votazione a New York della sopra citata Risoluzione dell’Assemblea Generale.
A ben vedere, una iniziativa unilaterale - per quanto criticata nelle capitali occidentali - rimane comunque preferibile all’inazione. D’altronde, i rapporti cino-americani sono caratterizzati in questo periodo da profonde divergenze di fondo (le abbiamo evocate nell’editoriale di settembre, dedicato alla delicatissima situazione di Taiwan), ulteriormente acuite dal più recente episodio dei “palloni spia” (veri o presunti). Irrealistico ipotizzare un percorso condiviso dalle due super-potenze, se si considera il rinvio della programmata missione a Pechino del segretario di Stato Usa Blinken, tappa obbligata per lo svolgimento di quel vertice fra i presidenti Biden e Xi Jinping in origine fissato per quest’anno e reso ora temporalmente più incerto.
Come considerazione finale, due richiami al passato. È opinione comune fra gli storici che gli esiti del Congresso di Vienna del 1815 permisero alla nazione sconfitta, in quel caso la Francia, di reintegrarsi progressivamente e senza eccessivi traumi nel nuovo ordine internazionale, a beneficio non solo proprio ma anche di quest’ultimo. Nelle valutazioni di molti di essi, un analogo atteggiamento non si verificò, circa 100 anni più tardi, a Versailles nei riguardi della Germania, che proprio sul “carattere ingiusto” delle imposizioni subite, basò la serie di rivendicazioni - economiche, militari e territoriali - sfociate, con l’avvento del nazismo, nei noti e tragici eventi successivi.
Ritornando ai giorni nostri, è certamente auspicabile che la compattezza e la fermezza dell’Occidente contribuiscano a provocare la caduta del regime attualmente insediato al Cremlino, postosi per scelta propria, e senza alcuna necessità, al di fuori di ogni accettabile quadro di legalità. Per quanto indelebili rimangano le immagini dei massacri di Bucha, di Irpin e di altre città ucraine è opinione di chi scrive che il modello da applicarsi nei confronti della Russia post-Putin sia esattamente quello “viennese”. L’obiettivo da raggiungere è il rientro nel normale circuito di collaborazione e interazione fra Stati, di un Paese di fondamentale rilevanza su scala mondiale che, oltretutto, è parte imprescindibile della geografia paneuropea. Il classico caso, in estrema sintesi, in cui il fine giustificherà i mezzi.
Il Reggente Marco Marsilli