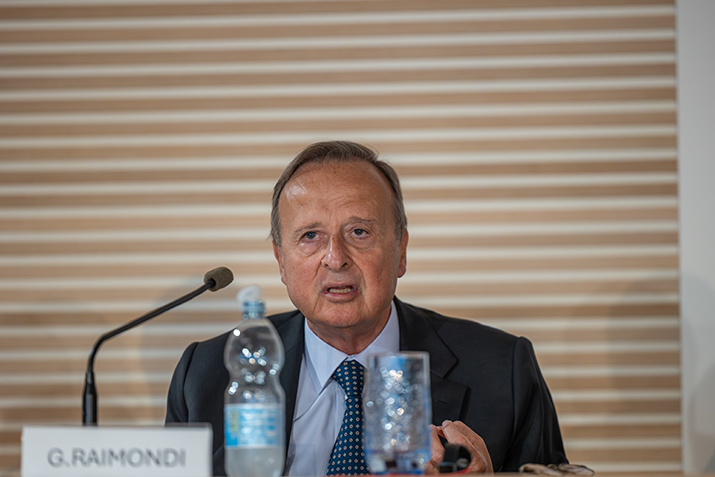SEMINARIO ALLA CAMPANA
LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E IL DISORDINE MONDIALE: LA RISPOSTA DEL CONSIGLIO D’EUROPA
Il sistema europeo di tutela dei diritti umani, creato dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), si trova ad affrontare una convergenza di crisi che ne minacciano l’efficacia e la legittimità. Due sviluppi emergono come particolarmente preoccupanti: la sistematica erosione dei principi democratici in diversi Stati europei e il profondo impatto della guerra della Russia contro l’Ucraina sull’architettura europea dei diritti umani.
La manifestazione più visibile dell’erosione democratica in Europa è stato l’indebolimento delle istituzioni liberal-democratiche, soprattutto in Ungheria e Polonia. Entrambi i Paesi hanno sperimentato ciò che si usa definire “esaltazione dell’Esecutivo”, ovvero una tendenza alla concentrazione del potere nell’esecutivo a scapito dei controlli e degli equilibri democratici.
Queste esperienze si inseriscono in una più ampia tendenza in tutta Europa. Il Parlamento europeo ha espresso profonda preoccupazione, lanciando l’allarme con una Risoluzione del 28 febbraio 2024 circa «un arretramento democratico in molti Stati membri» e ha individuato minacce specifiche tra cui problemi di indipendenza della magistratura, corruzione, libertà dei media e indipendenza delle autorità di controllo.
Questa erosione democratica pone sfide dirette al sistema della CEDU in diversi modi. In primo luogo, essa mina il principio di sussidiarietà che è alla base del sistema della Convenzione, ovvero l’idea che le autorità nazionali debbano essere i principali garanti dei diritti umani. L’indebolimento delle istituzioni nazionali di garanzia riduce l’efficacia dei rimedi a livello nazionale, per cui i singoli devono rivolgersi più frequentemente a Strasburgo, così aumentando il carico di lavoro della Corte e creando tensioni con i governi nazionali.
In secondo luogo, i governi populisti hanno sempre più utilizzato gli attacchi alla Corte come parte della loro più ampia narrativa contro le istituzioni internazionali e le cosiddette “élites corrotte”. Questi attacchi spesso invocano la “volontà del popolo” per giustificare le violazioni dei diritti delle minoranze e degli obblighi internazionali. La Corte si trova ad affrontare la sfida di mantenere la propria autorità operando in un contesto in cui la sua legittimità è sistematicamente messa in discussione da alcuni degli stessi Stati che dovrebbe supervisionare.
Alle preoccupazioni legate all’erosione del principio democratico si aggiungono quelle legate al preoccupante contesto geo-politico, nel cui quadro spicca per gravità la crisi ucraina, nel cui ambito è maturata l’espulsione della Russia dal Consiglio d’Europa. Il cambiamento istituzionale più drammatico nei 75 anni di storia del Consiglio d’Europa si è verificato il 16 marzo 2022, quando il Comitato dei Ministri ha deciso che la Russia «cessa di essere membro del Consiglio d’Europa», in seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, una decisione senza precedenti dalla fondazione dell’organizzazione nel 1949. L’espulsione della Russia ha avuto conseguenze immediate sul sistema della CEDU, determinando l’uscita di questo Paese anche dalla Convenzione a partire dal 16 settembre 2022.
Il 9 luglio 2025, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’Uomo ha emesso una delle sentenze più significative della sua storia nel caso Ucraina e Paesi Bassi contro Russia.
Questa decisione unanime ha ritenuto la Russia responsabile di diffuse e flagranti violazioni dei diritti umani per oltre otto anni, dal 2014 al 2022. Il catalogo di violazioni per le quali la Corte ha ritenuto la Russia responsabile è impressionante. Queste violazioni includono: attacchi militari indiscriminati; esecuzioni sommarie; tortura, in particolare lo stupro come arma di guerra; detenzioni illegali e arbitrarie; intimidazioni e persecuzioni di giornalisti e gruppi religiosi; saccheggi e distruzione di proprietà private; e il trasferimento organizzato di bambini ucraini in Russia e la loro adozione in Russia. La sentenza è importante anche dal punto di vista giurisprudenziale per quanto riguarda i temi della giurisdizione e dell’attribuzione. La Corte ha stabilito che la Russia aveva giurisdizione, ed era quindi tenuta ad osservare gli obblighi previsti dalla Convenzione, in relazione al territorio da essa occupato in Ucraina.
Questo, dunque, il difficile contesto nel quale si colloca la nostra riflessione sul futuro del sistema della Convenzione. Un contesto reso ancora più complesso da una rinnovata pressione politica sulla Corte di Strasburgo.
Nel maggio 2025, una coalizione di nove Stati membri dell’UE – Italia, Belgio, Danimarca, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca e Austria – ha pubblicato una lettera aperta in cui criticava l’interpretazione della Convenzione da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo, in particolare per quanto riguarda i casi di migrazione. I firmatari hanno sostenuto che la Corte ha «esteso eccessivamente l’ambito di applicazione della Convenzione rispetto alle intenzioni originarie della Convenzione, alterando così l’equilibrio tra gli interessi che dovrebbero essere tutelati». Hanno criticato in particolare la giurisprudenza della Corte in materia di espulsione di cittadini stranieri criminali, sostenendo che impedisce un’efficace gestione della migrazione. La lettera è stata ampiamente criticata da organizzazioni per i diritti umani e giuristi. Tuttavia, è un dato di fatto rilevante, del quale si deve tenere il debito conto.
Il sistema della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo si trova ad affrontare una convergenza senza precedenti di sfide che ne minacciano l’efficacia e la legittimità. Queste sfide si intersecano con le pressioni emergenti che plasmeranno il futuro della tutela dei diritti umani in Europa. La rivoluzionaria giurisprudenza della Corte in materia di cambiamenti climatici ha aperto nuove frontiere per la tutela dei diritti, generando al contempo una reazione politica da parte degli Stati preoccupati per l’eccesso di potere giudiziario. L’ascesa dell’intelligenza artificiale e del processo decisionale algoritmico presenta sfide tecniche che richiederanno nuove cornici interpretative. Le migrazioni indotte dal clima minacciano di sopraffare i sistemi di protezione esistenti, evidenziando al contempo le lacune del diritto internazionale.
Guardando al futuro, il sistema della CEDU deve adattarsi per rimanere efficace, preservando al contempo la sua missione fondamentale di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ciò richiede un approccio istituzionale che migliori la trasparenza e la responsabilità, pur mantenendo l’indipendenza della Corte di Strasburgo. Le sfide che la Convenzione deve affrontare non sono solo problemi tecnici o giuridici, ma riflettono tensioni più ampie nella società europea in materia di identità, sovranità e valori. Il percorso da seguire richiede il riconoscimento che il sistema della CEDU, come le società democratiche che serve, non è un’entità fissa, ma un’istituzione viva che deve evolversi per rimanere rilevante. Tuttavia, questa evoluzione deve essere guidata dai valori fondamentali che hanno ispirato la creazione della Convenzione: cioè la convinzione che la dignità umana trascenda i confini nazionali e che la cooperazione internazionale sia essenziale per la tutela dei diritti e delle libertà che rendono possibile la vita democratica.
Guido Raimondi

Guido Raimondi durante il suo intervento al seminario